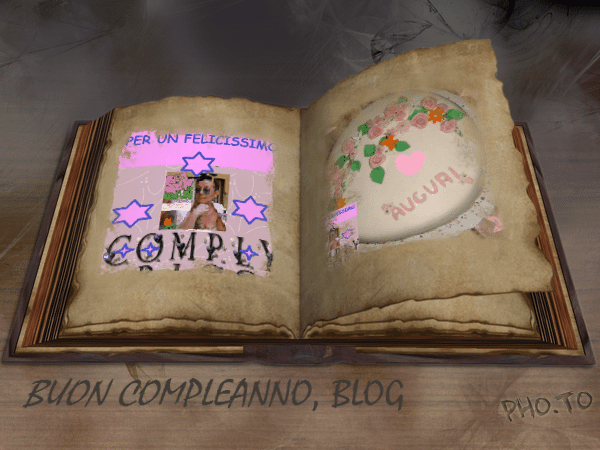ABRUZZO, LA MARSICA...INCONTRO CON SILONE
La Marsica si trova nell'Abruzzo interno (QUI IMPORTANTI CENNI STORICI), terra di origine dell'antico e combattivo popolo dei
Marsi, (nonchè della famiglia di mio padre ). Luogo ricco di storia e di
natura: del resto l'orso bruno marsicano prende il nome da
questa terra. Regione, zona che ha visto numerosi cambiamenti, trasformazioni sociali ed
economiche, territorio a misura d'uomo che spesso ha dovuto subire (per
il bene di pochi) soprusi da parte di popoli invasori, signorotti e
politici.
La Marsica era
caratterizzata fino alla fine del XIX secolo, dalla presenza del lago Fucino, uno dei più grandi del nostro Paese.
 |
| ANTICA MAPPA |
L'economia era basata sulla
pesca e sulla coltivazione di ulivi e alberi da frutto cosa resa
possibile, fra le montagne abruzzesi proprio, dalla presenza del bacino
idrico che mitigava il clima premettendo la presenza di quel genere di
colture.
 |
| LAGO DEL FUCINO |
Terminati nel 1878 i lavori di prosciugamento del lago, il Fucino subì una profonda trasformazione sia
economica che sociale: non era più possibile pescare e l'assenza del
lago portò ad un irrigidimento del clima che non permise più la
coltivazione degli alberi da frutto. Tutta la conca del Fucino si trovò in un grave stato
di povertà e miseria.
 |
| CANALE COLLETTORE PER IL PROSCIUGAMENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DUNQUE ...l’acqua nella realtà
ambientale del romanzo...
L'equilibrio alimentare e
produttivo ancora oggi si basa sulla disponibilità ma anche sul
controllo dell'acqua. Anche il più piccolo corso d' acqua
garantisce una produzione agricola. Le acque amiche o nemiche per
alluvioni, frane, fiumare sono causa dell'abbandono o
dell'arroccamento della popolazione di un paese, di
stabilità o mobilità delle popolazioni. Sorgenti,canali, fontane
diventano punto di incontro e di riposo presso i quali i contadini si
incontrano, parlano e si scambiano osservazioni. Ma non solo: i
«luoghi d' "acqua" diventano anche luoghi di socializzazione e di
trasgressione. Le antiche civiltà fluviali hanno trovto in questo elemento la base della loro prosperità, offrendo
un terreno di incontro di scambio e di contatto tra diverse culture e
incidendo profondamente sulla distribuzione degli insediamenti umani
e sulle loro vicende. Ogni comunità rivierasca intreccia un legame
materiale e simbolico che esprime anche nella dimensione culturale.
Nel Sud dell'Italia la
presenza di irrigazione nelle campagne ha sempre marcato una
divisione tra la coltivazioni estensive e ricche e la piccola media
proprietà : in Fontamara di Silone, il podestà del paese e i
proprietari terrieri sottraggono ai contadini persino l'acqua con la
quale irrigano gli orti da cui ottengono i pochi prodotti che
assicurano un precario sostentamento. Nel romanzo l'acqua, elemento
vitale, assurge a metafora dell'oppressione che conoscono le
popolazioni meridionali, della loro volontà di riscatto e rinascita.
LA FONTE AMARA
La prima opera, "Fontamara", a cui ancora oggi è legata la notorietà di Silone in misura
maggiore, dentro e fuori dall'Italia, fu scritta nel 1930 a Davos, in
Svizzera: nome immaginario di un piccolo
villaggio di montagna, derivato da Fonte amara, ricco di significati
allusivi per i fatti che vi si svolgono.
Nel 1948, dopo 18 anni di
notorietà internazionale, la casa editrice Mondadori pubblica il
volume Fontamara di Silone, simbolo dell' Universo
contadino - paese marsicano.
Autore: Ignazio Silone,
pseudonimo di Secondo Tranquilli, nato a Pescina l’1/5/1900 e morto
a Ginevra il 22/8/1978.
Titolo: Fontamara.
Editore: Arnoldo
Mondadori Editore, collana “Oscar Mondadori”.
... 36 anni fa avveniva la sua morte....scrittore dalla parte dei "cafoni"
 |
| DOVE E' SEPOLTO |
AMBIENTAZIONE DEL ROMANZO
" A chi guarda Fontamara da
lontano, l'abitato sembra un gregge di pecore scure e il campanile un
pastore. Un villaggio insomma come tanti altri, ma per chi vi nasce e
cresce, il cosmo".
(I. Silone, Fontamara).
Nella prefazione
del libro, prima fondamentale testimonianza della poetica di Silone,
l'autore afferma di aver dato questo nome a un "antico e oscuro
luogo di contadini poveri situato nella Marsica, a settentrione del
prosciugato lago di Fucino, nell'interno di una valle, a mezza costa
tra le colline e la montagna ». E, quasi a voler sottolineare il
nesso per lui indissolubile tra invenzione fantastica e realtà
storica, oltre che la proiezione universale degli « strani fatti »
accaduti nel corso di un'estate, aggiunge:
« Fontamara somiglia
dunque, per molti lati, a ogni villaggio meridionale il quale sia un
po' fuori mano, tra il piano e la montagna, fuori delle vie del
traffico, quindi un po' più arretrato e misero e abbandonato degli
altri. Ma Fontamara ha pure aspetti particolari. Allo stesso modo, i
contadini poveri, gli uomini che fanno fruttificare la terra e
soffrono la fame, i fellahin, i coolis, i peones, i mugic, i cafoni,
si somigliano in tutti i paesi del mondo; sono, sulla faccia della
terra, nazione a sé, razza a sé; eppure non si sono ancora visti
due poveri in tutto identici ».

 Fontamara, ideale
paesino di contadini poveri situato nella Marsica, è un po’ fuori mano. A chi sale al paese dalla piana del Fucino, appare disposto sul fianco della
montagna grigia brulla e arida come una gradinata. Sono
visibili le porte e le finestre della maggior parte delle case: un
centinaio di casucce quasi tutte a un piano, irregolari, informi,
annerite dal tempo e sgretolate dal vento, dalla pioggia, dagli
incendi, coi tetti mal coperti da tegole e rottami d’ogni sorta. La
maggior parte di quelle catapecchie non hanno che un’apertura che
serve da porta, da finestra e da camino. Nell’interno, per lo più
senza pavimento, con i muri a secco, abitano, dormono, mangiano,
procreano, talvolta nello stesso vano, gli uomini, le donne, i loro
figli e gli animali. La parte superiore di Fontamara è dominata
dalla chiesa (dedicata a San Rocco) col campanile ed una piazzetta a
terrazzo alla quale si arriva per una ripida via che attraversa
l’intero abitato, e che è l’unica via da dove posano transitare
i carri. Ai fianchi di questa vi sono stretti vicoli laterali, per lo
più a scale, scoscesi, brevi, coi tetti delle case che quasi si
toccano e lasciano appena scorgere il cielo. A chi guarda Fontamara
da lontano, l’abitato sembra un gregge di pecore scure e il
campanile il pastore. Un villaggio insomma come tanti altri.
Fontamara, ideale
paesino di contadini poveri situato nella Marsica, è un po’ fuori mano. A chi sale al paese dalla piana del Fucino, appare disposto sul fianco della
montagna grigia brulla e arida come una gradinata. Sono
visibili le porte e le finestre della maggior parte delle case: un
centinaio di casucce quasi tutte a un piano, irregolari, informi,
annerite dal tempo e sgretolate dal vento, dalla pioggia, dagli
incendi, coi tetti mal coperti da tegole e rottami d’ogni sorta. La
maggior parte di quelle catapecchie non hanno che un’apertura che
serve da porta, da finestra e da camino. Nell’interno, per lo più
senza pavimento, con i muri a secco, abitano, dormono, mangiano,
procreano, talvolta nello stesso vano, gli uomini, le donne, i loro
figli e gli animali. La parte superiore di Fontamara è dominata
dalla chiesa (dedicata a San Rocco) col campanile ed una piazzetta a
terrazzo alla quale si arriva per una ripida via che attraversa
l’intero abitato, e che è l’unica via da dove posano transitare
i carri. Ai fianchi di questa vi sono stretti vicoli laterali, per lo
più a scale, scoscesi, brevi, coi tetti delle case che quasi si
toccano e lasciano appena scorgere il cielo. A chi guarda Fontamara
da lontano, l’abitato sembra un gregge di pecore scure e il
campanile il pastore. Un villaggio insomma come tanti altri.
Nella premessa,
il narratore è lo stesso Silone. Le vicende, invece, sono
raccontate all’autore da tre fontamaresi (Giuvà, Matalè e il loro
figlio). L'autore immagina di
essere stato raggiunto nel suo esilio svizzero dai tre Fontamaresi: un
uomo, sua moglie e il figlio, i quali gli riferiscono gli ultimi
"strani" avvenimenti accaduti in paese. Questi sono fortunatamente scampati al massacro.
"Su Fontamara non ci sarebbe niente
da dire, se non fossero accaduti gli strani fatti che sto per
raccontare... Per vent'anni il solito cielo, circoscritto
dall' anfiteatro delle montagne che serrano il feudo come una
barriera senza uscita; per venti anni la solita terra, le solite
piogge, il solito vento, la solita neve, le solite feste, i soliti
cibi, le solite angustie, le solite pene, la solita miseria: la
miseria ricevuta dai padri, che l' avevano ereditata dai nonni, e
contro la quale il lavoro onesto non è mai servito a niente. Le
ingiustizie più crudeli vi erano cosí antiche da aver acquistato la
stessa naturalezza della pioggia, del vento, della neve. La vita
degli uomini, delle bestie e della terra sembrava cosí racchiusa in
un cerchio immobile saldato dalla
chiusa morsa delle montagne e dalle vicende del tempo".
(FONTAMARA, 1988, p.5)
I PERSONAGGI
Silone
fa innanzitutto una distinzione fra il bene e il male, identificati con
i cafoni e i galantuomini. Tutti i cafoni non vanno considerati
singolarmente, ma come un gruppo di persone sottoposte allo stesso
triste destino, descritte spesso in un modo piuttosto comico, che
riflette purtroppo la loro condizione: l’ignoranza, la povertà, la
fiducia ingenua nelle autorità, la diffidenza nei confronti del governo.
Con la cultura, i galantuomini possono ingannarli senza difficoltà; per
fortuna i fontamaresi hanno anche la “furbizia contadina” che consiste
nel trarre vantaggio anche da situazioni molto sfavorevoli, ad esempio
quando si fanno pagare da don Circostanza per i voti dei morti.
CARATTERISTICA CULTURALE
I
cafoni sono ignoranti, sono per lo più analfabeti: sanno fare solo la
propria firma. La mancanza di istruzione impedisce loro di capire il
discorso del cav. Pelino, e tale incomprensione è origine di molti
mali. Anche la politica risulta estranea ad essi: non sanno,
infatti, nulla del regime fascista allora al potere, e quando devono
gridare “Viva chi?” non sanno cosa dire.